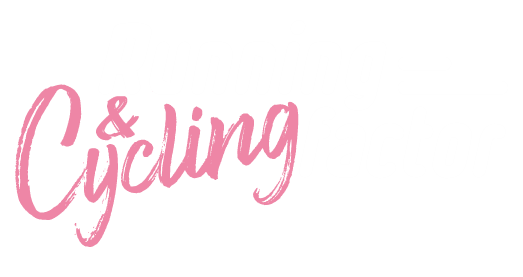Non c’è delusione né rabbia. C’è consapevolezza di aver dato tutto quello che il mio corpo era in grado di dare in quella circostanza, durante la maratona di domenica scorsa.
Cosa mi ha portato a Rotterdam? Un desiderio. Il desiderio di correre più velocemente di chi ero ieri, dimenticandomi per un attimo che avrei dovuto fare i conti con chi sono oggi.

È stata la maratona più difficile da portare a casa, in cui mi sono trovata a dare tutto anche se non mi rimaneva più niente da dare. Mi sono presentata sulla linea di partenza credendoci. Sono partita provandoci. Ma alla fine non ce l’ho fatta.
Non ho seguito le indicazioni di Matteo, il coach, che mi aveva detto di partire conservativa per poi vedere come si sarebbe messa la situazione. Di vedere come avrebbe reagito la mia gamba sinistra. Già, perché a preparazione inoltrata, dopo un’ecografia e una risonanza magnetica ho scoperto di soffrire di una tendinite al bicipite femorale, un’infiammazione non particolarmente facile né veloce da far passare, causa di un dolore cronico che ha segnato ogni allenamento e ogni gara di avvicinamento alla maratona.

Mi rendo conto che parlare con uno sportivo non è facile. Lui non ti ascolterà né tanto meno farà quello che gli verrà detto se questo andrà contro i suoi programmi. Per questo mi ritengo fortunata perché ho trovato persone comprensive disposte ad aiutarmi senza stravolgere i miei piani. Insieme abbiamo fatto il possibile, ma non è stato abbastanza.
Mai avrei immaginato di dover gestire oltre a questo anche altri problemi. Passata la mezza maratona mi sentivo già completamente esausta. Avevo corso e gestito la prima metà di gara esattamente come avevo fatto a dicembre a Valencia, solo che questa volta non avevo abbastanza energie per riuscire a tenere lo stesso ritmo per altri 21km. Ero letteralmente e completamente esplosa.

I miei pensieri avevano iniziato a correre più velocemente di quanto stessero facendo le mie gambe. E ora cosa faccio? Per la prima volta ho pensato di ritirarmi da una gara. Proseguire sarebbe stato troppo per le condizioni in cui ero. Dove avrei trovato le energie per raggiungere il traguardo? Le domande si affollavano nella mia testa senza che riuscissi a dar loro una risposta. Ormai era chiaro che non sarei più riuscita a correre per performare. Dovevo cambiare punto di vista e cercare un altro buon motivo per continuare. Ho girato il quadrante dell’orologio per non essere condizionata dai dati, ho rallentato e cercato un nuovo ritmo che fossi in grado di gestire. E come un mulo ho proseguito lungo la mia strada.

Nella seconda parte di gara ho sofferto la sete e il caldo. I ristori disposti ogni 5km non mi sono stati sufficienti, nonostante a ciascuno bevessi due bicchieri colmi d’acqua. Prendevo le spugne che mi porgevano i volontari e me le strizzavo in testa nel tentativo di recuperare un po’ di lucidità. Più di una volta ho pensato di mettermi a camminare. Ma camminando il tempo si sarebbe dilatato e mi sarebbe sembrato infinito, rendendo tutto ancora più difficile. Poi sarebbe stato impossibile camminare in mezzo a tutta quella folla di gente che applaudiva, si sbracciava e urlava il mio nome da destra e sinistra. Più mi vedevano in difficoltà e più mi incitavano. Se tutte queste persone stavano perdendo l’utilizzo delle corde vocali per me, io potevo resistere e continuare a correre per loro.
Not fast, just furious. Tra tutti i cartelloni e striscioni che ho visto sventolare in aria lungo il percorso questa frase mi è rimasta impressa nella mente dal primo momento in cui l’ho letta. Ho pensato che fosse la perfetta descrizione della mia gara.

Ero fisicamente esausta ma mentalmente ancora lucida. Al trentesimo chilometro sapevo perfettamente dove mi trovavo. Avevo superato il Markthal e le caratteristiche case cubiche. Mancavano ancora una decina di chilometri da correre intorno al parco Kralingse Plas, un luogo familiare in cui avevo già fatto una corsetta di ricognizione nella giornata di venerdì insieme all’Andre, il mio compagno di trasferta. Durante la maratona mi ha rincorso in lungo e in largo per la città per supportarmi e catturare attimi da ricordare.

È stata una gara complessa, una gara difficile, che ricorderò non tanto per il crono finale, che ho fermato a 3 ore 29 minuti e 24 secondi ma per l’impatto, fisico ed emotivo che ha avuto su di me. Le premesse non erano buone e dal punto di vista della performance non è di certo stata la gara che avevo immaginato. Ma come mi ha scritto a posteriori Matteo “maratone ce ne sono tante, di corpo ne hai uno solo”.
Anche dal punto di vista della manifestazione le mie aspettative non sono state rispettate, in questo caso sono state completamente surclassate. Anche nei punti più lontani e remoti, quando ci siamo trovati a correre in una zona per lo più residenziale in mezzo alla campagna, gruppi di persone erano lì, a vivere la maratona da un altro punto di vista, ma non per questo con meno entusiasmo e passione.

Oggi mentre scrivo ho quasi l’impressione di non averla nemmeno corsa questa maratona. I muscoli sembrano essersi già dimenticati dello sforzo, ma questo non significa che il mio corpo non abbia bisogno di recuperare, ma soprattutto di guarire. Ne ha forse più bisogno che in passato dato il crollo energetico che ha segnato la mia gara. Cercherò le risposte e farò quello che ci sarà da fare per tornare come prima più di prima.
Questa maratona mi ha ricordato di quanto sia fortunata di poter essere ancora qui a fare, parlare e scrivere di quello che amo, una fortuna che non posso dare per scontata, perché dall’oggi al domani potrebbe essermi strappata senza motivo, solo per volere del destino. Questa mia quindicesima maratona la dedico a un campione a cui è stata strappata per sempre questa possibilità e che avrebbe dovuto essere a Rotterdam. Per te Kelvin.